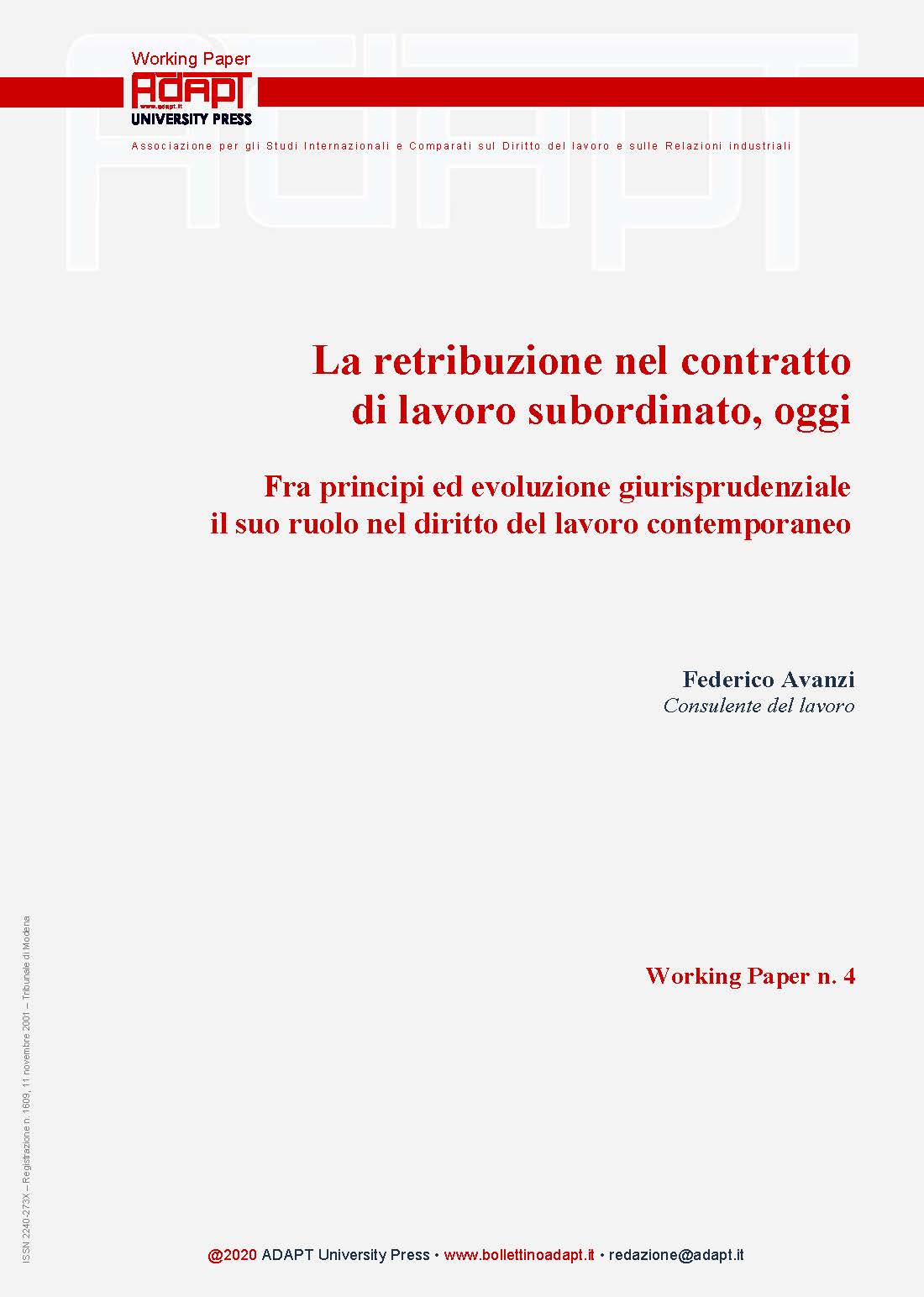Maturata l’esperienza circa gli effetti delle politiche orientate alla “flessibilizzazione” del mercato del lavoro, non può non ravvisarsi che del concetto di flexicurity, sia stata certamente realizzata una maggior flessibilità contrattuale, piuttosto che la sicurezza nelle transizioni professionali dei lavoratori.
Questo induce a interrogarsi sulla sopravvivenza, nel diritto contemporaneo, di riferimenti certi, che consentano di dare senso, e sostanza, alla distinzione fra prestazioni eterodirette o svolte in modalità autonoma. A ben vedere, l’istituto che è apparso meno permeabile al senso di marcia impartito, sembra essere proprio una delle obbligazioni principali scaturenti dal sinallagma subordinato: la retribuzione.
L’analisi che segue ha dunque l’obbiettivo, valorizzando la preziosa attività della magistratura, di mettere in luce i differenti recetti che regolano e, a tutti gli effetti, proteggono imperituri, ed anzi evoluti, il diritto essenziale del lavoratore ossia il dovuto corrispettivo per la prestazione resa.
Dall’esclusivo e ampio concetto di giusta retribuzione, al temperato principio di corrispettività (vs obbligatorietà), dal consolidato diritto di irriducibilità ai nebbiosi confini dell’assorbimento, dall’indeterminatezza della onnicomprensività degli istituti differiti alla partita, sempre aperta, della prescrizione e, soprattutto, della sua decorrenza. Indirizzi e criteri, non alternativi fra loro e che sanciscono il ruolo chiave della retribuzione, dovuta al lavoratore dipendente, nel garantire il riequilibrio della disparità di forze coinvolte nel rapporto e nell’arginare, de facto, una eccessiva avanzata della flessibilità contrattuale.